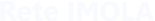È morta, giovanissima, Marina Sangiorgi.
Pare necessario che uno scrittore muoia perché se ne comprenda e se ne soppesi davvero l’importanza. Anzi, forse il vero scrittore, che parla per tutti, anche e soprattutto per i posteri, è già morto in vita, già postero di se stesso, solidale con il punto di vista di chi lo leggerà, o potrebbe leggerlo, fra un secolo o un millennio. Il che può in parte raddolcire un poco il lutto e il vuoto della sua perdita, della fine, prematura o tardiva, della sua vicenda terrena, che è in fondo la parte più caduca, più esteriore, meno essenziale, della sua vicenda.
Nel mio personale caso, è stato necessario proprio il nero lampo di questa morte prematura e inattesa perché mi si rivelasse, d’un colpo, anzi perché io fossi indotto a riconoscere e a ripensare, rievocando vecchie letture sedimentatesi in un angolo della memoria, l’importanza dell’autrice.
Marina era ‒ anzi resta, e resterà ‒ una scrittrice elegantissima, di una levità assoluta, di un lirismo intimo, misurato, squisito, che sembra fatto di nulla, di “cose leggere e vaganti”, intriso di una leggerezza insostenibile, ed è invece intensissimo, essenziale, vissuto, calibratamente meditato e dosato.
Del resto, avevo l’impressione che, anche nella realtà, Marina attraversasse la vita come se fosse un sogno, con un candore, una lontananza, una specie di perpetua e vigile assenza, che parevano quasi infantili, e invece forse erano il segno denso eppure diafano di una sapienza silenziosa e più alta.
Mi disse una volta che dovevo affrontare con spirito di accettazione e rassegnazione a Dio i miei due acerbi lutti familiari. Mi sembrava che il suo rigore, la sua autentica, testimoniata, coerenza, il suo “integralismo”, come si dice con brutto termine, cattolico avessero addirittura qualcosa di inumano. Ma, forse, la vera Fede è sempre inumana, perché è al di sopra dell’uomo. Ora invece la fermezza e il silenzio e la dignità con cui ha affrontato la sua malattia ne sono la prova innegabile, l’incarnata e umanissima attuazione.
Come dimostra una stupenda prosa, Mi basta l’aria, affidata alla rete, (credo il suo testamento letterario e spirituale, il suo addio all’esistenza terrena e insieme alla scrittura, e con essa alla limitatezza, al peso, alla materialità a volte opaca e sorda, della parola ‒ una pagina il cui vero e pieno senso si chiarisce solo ora, nella luce del dopo): serena accettazione di un destino, e anzi attesa fiduciosa e quasi amorosa del suo compimento.
«Aspetto i secoli e i secondi che mi separano dal risalire dalla polvere, il tornare a essere, perché voglio la salute e la salvezza, voglio la libertà nella salvezza, la voglio ora e invece devo aspettare, vegliare nella notte per miliardi di secoli. I miliardi di secoli sono come un battito di ciglia, eppure i giorni sono lunghi come l’eternità». Forse, un sottile, fioco intarsio di velati echi danteschi («la dolce vita», la «serena / che ha nome vita», vagheggiata e rimpianta nell’ora del tormento; il tempo umano che è «un batter di ciglia» a paragone dell’eterno; «la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara», la carne sofferente che rinascerà «corpo spirituale») tratteggiato e cesellato alle soglie dell’oltre, ad un passo dall’ultimo viaggio, a un attimo soltanto da ciò che è fuori dal tempo.
Tutto deve restare sulla pagina, ogni minimo istante, ogni minimo sguardo, ogni fotogramma fuggevole: «Sto male e mi accorgo che l’aria è bella e gli alberi alla sera sono bellissimi, si imbrunano e le foglie si muovono all’aria leggera, e tutto è dolce, una meraviglia, una bellezza spropositata e immeritata».
C’è qualcosa di autenticamente, di profondamente cristiano, di francescano, in questo amore indistinto, eppure particolare, individuale, per tutti, per il tutto, per la vita in tutte le sue manifestazioni, addirittura, quasi, per lo stesso dolore, per la morte stessa, per “sorella morte”. «Ogni giorno è clamoroso, è un clamore di desiderio e amore, ogni giorno è tutto, e non voglio niente, non chiedo più niente, mi basta l’aria». Come in Jacopone da Todi: «Amor, amore grida tutto ‘l mondo, / amor, amore, onne cosa clama; / amor, amore, tanto se’ profondo, / chi più t’abraccia sempre più t’abrama».
Forse, del resto, insegnano oggi alcuni filosofi, tutto è eterno, perché la stessa eternità è un istante: ogni minimo evento è immobile e immutabile come l’eternità, ha la fissità imperitura del lampo e del fotogramma, dello sguardo, della parola stessa che lo nomina, insinuata fra le minute pieghe, le fibre infinitesimali e remotissime, del linguaggio; a paragone dell’eterno, e in relazione all’eterno, l’istante e il millennio sono uguali; e noi risorgeremo insieme a tutto il tempo, ad ogni singolo istante, che dall’eterno ci è venuto incontro, e che nell’eterno riportiamo insieme a noi.
E si avverte, precisamente, in questo minuzioso soffermarsi su dettagli minimi, ma osservati, quasi amorevolmente accarezzati, con uno sguardo solerte, attentissimo, quasi materno, tutto il carattere di Marina, che io ricordo, durante quelle circostante spesso vuote che sono conferenze, seminari, presentazioni, incontri, curva sui suoi taccuini a prendere meticolosamente appunti, come se neppure una parola dovesse sfuggire, come se tutto dovesse essere sottratto alla fuga del tempo, allo svanire delle cose, deposto nella custodia della pagina scritta.
Mi torna in mente allora un suo vecchio articolo uscito su “Università Aperta”, che, a proposito dei taccuini di Luigi Orsini, poeta ‒ notava l’autrice ‒ tanto modesto quanto appassionato, sottolineava proprio l’importanza della memoria, della memoria scritta, anche intorno a quei minimi eventi, a quelle frasi fuggevoli, a quei quasi fluenti ed evanescenti sguardi gesti moti parole, in cui comunque si manifestano e brillano, intermittenti, la luce dell’essere, l’epifania della creaturalità, e che dunque meritano di lasciare una traccia, di divenire testimonianza e ricordo. Come se la scrittura fosse, per così dire, nel tempo, vicaria e messaggera dell’eterno.
E si può rileggere, ora, con altri occhi, forse nel suo vero senso, anche la chiusa di un racconto (La vita azzurra vola) uscito in una sede prestigiosissima, su una delle grandi riviste del Novecento italiano, «Nuovi Argomenti»: «… a meno che stavolta per miracolo dopo la rincorsa e il salto, mentre affondo nel vuoto, a un passo dal suolo invece di rovinarmi, di frantumarmi in mille pezzi, io riesca a sollevarmi, con una spinta delle gambe, e impari a spalancare le braccia, a planare, a volare, a salire, e infine appoggiarmi, delicatamente, nell’aria come fosse acqua».
Viene in mente, ora, non tanto la “leggerezza” fin troppo decantata nel secondo Novecento, e che tanto spesso si risolve in svagatezza e inconsistenza; ma, piuttosto, il tuffatore di un bellissimo affresco in una tomba di Paestum, forse allegoria dell’anima che si libera dal corpo ‒ e si può pensare, ora, che la parola dello scrittore è alata come l’anima, vince il peso del tempo come quello dell’aria.
Se ne va (anzi resta nelle sue pagine), insomma, una scrittrice di un’eleganza e una finezza, e direi di un pudore, rarissimi, quintessenziali. Il suo lascito è, per questo, ancora più prezioso, in un’epoca sovrabbondante, caotica, debordante, e tanto spesso volgare, come quella in cui ci è dato vivere.
Matteo Veronesi